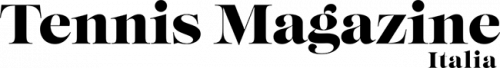Sinner, Gazzetta, Coppa Davis, articolo 19
Le pesanti critiche della Gazzetta dello Sport a Jannik Sinner partono dal principio secondo cui giocare in nazionale sarebbe un obbligo. Sbagliato: la Davis è meravigliosa e dovrebbe essere una priorità, ma chi non la pensa così non può essere oggetto di attacchi e pressioni. E pensare che i regolamenti FITP prevederebbero la squalifica di Jannik (e Vagnozzi)...
Riccardo Bisti | 27 settembre 2023 |
Potesse parlare, l'Insalatiera avrebbe mille cose da raccontarci. Da quando fu decorata con 217 once d'argento donate da Dwight Davis, ha visto di tutto. Il bello e il brutto del tennis, spalmato in 123 anni. Si trovava a Bologna quando è iniziato il Sinner-Gate, una serie di articoli giornalistici usciti sulla Gazzetta dello Sport con una regolarità tale da lasciare perplessi. Reo di aver detto no alla convocazione per il girone contro Cile, Canada e Svezia, il numero 1 azzurro è stato criticato sulle edizioni del 14 settembre (subito dopo il capitombolo contro il Canada) e del 15 (con interviste a ex atleti olimpici che ribadivano il valore della Maglia Azzurra), mentre domenica 17 era stato definito Signor No... e non era un omaggio a Lodovico Peregrini. Finita la Davis, finite le polemiche? Macché: il numero successivo di Sportweek, settimanale patinato in edicola ogni sabato insieme al quotidiano, ha dedicato la copertina e parecchie pagine per stigmatizzare la scelta sinneriana di allenarsi a Monte-Carlo anziché giocare contro Diallo, Jarry e Ymer.
Si è acceso un focolaio alimentato dai social media, sfondo fin troppo invadente nella vita di ognuno di noi. Come era prevedibile, l'attacco è stato talmente mirato e – a nostro avviso – debole nelle argomentazioni, che il popolo degli internauti si è schierato più o meno compatto a favore di Jannik, che ha scelto il silenzio e oggi si trova a Pechino, laddove esordirà contro Daniel Evans. Se la scelta di Jannik è certamente criticabile, il modo in cui è stata condannata dal principale quotidiano sportivo ha alimento un meccanismo di difesa collettiva che non ha certo aiutato la rosea... semmai Mark Zuckerberg ed Elon Musk. Secondo noi, la faccenda va affrontata da due prospettive: il valore umano-sociale della Coppa Davis (cosa ben diversa rispetto al suo spessore tecnico) e il presunto obbligo morale di giocarla. Aspetti cruciali che sono stati messi in secondo piano, quasi ignorati, in nome di una narrativa che mirava alla pancia del lettore, specie il meno preparato, in cerca di facile indignazione.
E allora ci proviamo noi, a entrare nella polpa della questione.

Regolamento Giustizia FITP, Articolo 19
Al netto del disastro combinato nel 2018, la Coppa Davis è la manifestazione che più di tutte mette alla prova qualità umane e morali. Per essere un davisman bisogna essere temprati nel cuore, nella mente e nell'anima. È la competizione in cui è necessario uscire dalla zona di comfort per essere vincenti. Le pressioni sono decuplicate, ogni punto pesa come un macigno. Fisico e mente si esauriscono e in palio c'è soprattutto la gloria, perché i montepremi (salvo l'infelice parentesi Kosmos) sono generalmente trascurabili. Ma rimane la memoria, l'epica, il sapore di storia da raccontare. Chiedete cos'è la Coppa Davis a Nicolas Lapentti: nel 2009 era prossimo al ritiro, aveva un ginocchio a pezzi, eppure si presentò l'occasione di riportare l'Ecuador nel Gruppo Mondiale. Andò a Porto Alegre e fece un miracolo contro il Brasile, regalando ai suoi tre punti, restando in campo per quasi dodici ore e quindici set. Un famoso spot diceva che una telefonata allunga la vita, di certo la Davis ha allungato la carriera di Lapentti. Chiedete cos'è la Coppa Davis a Byron e Wayne Black, i fratelli d'oro dello Zimbabwe. Avevano imparato a giocare in un frutteto, laddove papà Don aveva fatto costruire cinque campi da tennis e ogni santa mattina li buttava giù dal letto alle 5.20 per allenarli. Quegli allenamenti servirono per battere l'Australia a domicilio nel 1998, sull'erba spelacchiata di Mildura, sede periferica scelta dagli aussies perché avrebbe dovuto essere una passeggiata. Invece, nonostante un viaggio di 22 ore, i Black Brothers vinsero 3-2 per la commozione dei due giornalisti zimbabwesi al seguito. Uno di loro, Tichanoa Sibanda, telefonò alla redazione di SW Radio Africa per comunicare il risultato. Dall'altra parte della cornetta sentì un fragoroso applauso dei colleghi, che pochi minuti dopo diffusero la notizia in tutto il Paese. Chiedete cos'è la Coppa Davis a David Nalbandian, che pur di vincerla avrebbe restituito qualsiasi trofeo individuale. Nel 2010 era infortunato e non avrebbe potuto partecipare al match contro la Svezia. Senza di lui era sconfitta annunciata, ma 3-4 giorni prima della partita – quando i compagni erano già a Stoccolma – iniziò a sentirsi meglio. Al mercoledì prese la folle decisione: saltò su un aereo e fece Buenos Aires-Stoccolma, con tanto di scalo. Arrivò a sorteggio già effettuato e non ebbe tempo per provare il campo. Risultato? Vinse il doppio insieme a Horacio Zeballos e poi diede il punto del 3-2 battendo Andreas Vinciguerra. Il tutto in nome del suo ideale.

Chiedete cos'è la Coppa Davis a Hugo Chapacu. Chi? Un modesto giocatore a cui si deve il punto più basso nella storia degli Stati Uniti. Fu lui, nel 1987, a vincere un clamoroso match contro Jimmy Arias in Paraguay-Stati Uniti. Sostenuto da un pubblico che abbaiava (sì, abbaiava) contro gli americani, si trovò in svantaggio 5-1 al quinto set. I telecronisti della TV americana stavano smontando i cavi, avevano già ringraziato il pubblico, ma non fecero i conti con una rimonta folle, terminata intorno alla mezzanotte. 9-7 al quinto e 2-2. La nottata terminò con la vittoria di Pecci su Krickstein e l'eliminazione degli americani, dopo che Chapacu era stato portato in trionfo, fino a stringere la mano al generale Stroessner. Chiedete cos'è la Coppa Davis a Jiro Sato, il più drammatico eroe di questa competizione. Considerato uno dei più forti nei primi anni '30, nel 1933 perse il singolare decisivo contro l'Australia. L'anno dopo fu costretto partire per la Gran Bretagna, anche se non se la sentiva e aveva forti dolori allo stomaco. Travolto dal senso di colpa, si gettò in mare nello Stretto di Malacca, avvolto da una corda e un paio di maniglie di vetro. Il suo corpo non è mai stato ritrovato. Oppure chiedete cos'è la Coppa Davis a Omar Camporese. Opinionista RAI durante la settimana di Bologna, da bambino era tifoso di Panatta e sognava ogni volta che c'era la Davis. “Volevo indossare la maglia azzurra e mi affascinava. Adoravo la cerimonia, nella quale gli atleti indossavano quel maglione che sembrava di lana pesante, con il tricolore sulla spalla sinistra. L'ho sempre sentita, voluta. Difendere i colori del paese mi dava qualcosa in più”. Adriano Panatta lo sapeva e lo reclutò con mesi d'anticipo per la campagna del 1997, rimettendolo a posto fisicamente e mentalmente dopo l'infortunio-killer al gomito. Un progetto culminato con il magico weekend di Pesaro, in cui (da numero 167) batté il numero 8 Carlos Moyà, regalando all'Italia una clamorosa semifinale. “Quando scendi in campo in Davis cambia tutto. Sei un'altra persona, forse è magia, entri in un mondo parallelo e vai. Le responsabilità ti portano a dare tutto quello che hai”.
Ci sarebbero altre decine di storie come questa. Dice bene Camporese: la Davis ti porta in un'altra dimensione, chiede tanto ma restituisce ancora di più. Però bisogna saperla comprendere, apprezzare e infine amare. Chiede una statura morale diversa.

Omar Camporese esulta con Adriano Panatta dopo il miracoloso successo contro Carlos Moyà: è il 4 aprile 1997
Nicolas Lapentti diventa eroe nazionale in Ecuador per la miracolosa impresa in Brasile
Gli esempi appena citati dovrebbero essere l'unica spinta per un giovane (come Sinner, come tutti gli altri) a desiderare di giocare. Dovrebbero accendere il fuoco interiore che dà la forza di mettere da parte gli interessi personali, non così banale in uno sport che alimenta l'egoismo. Ma deve essere un piacere, un sentimento, una spinta interiore. Non dovrebbe mai essere un obbligo. Chi non prova emozione quando c'è l'inno nazionale, vede come un fastidio una trasferta in Sudamerica quando il circuito si snoda altrove, o semplicemente preferisce fare altro (che siano allenamenti o tornei) non deve essere condannato, stigmatizzato o punito. Il tennis rimane uno sport individuale, in cui il giocatore ha il sacrosanto diritto di programmarsi come meglio crede. Dicono, gli sceriffi della parola: “Ognuno può fare quel che crede, però...”.
No, nessun però.
Possono esserci mille motivi per cui un tennista preferisce rinunciare alla Davis e non per questo deve passare come un traditore della patria o un reietto. Jimmy Connors non amava la competizione, anzi, non gliene importava nulla. In vent'anni di carriera ha giocato appena 13 partite, dando disponibilità completa solo nel 1984, ma nessun connazionale (salvo John McEnroe, ma quella è un'altra storia) si è sognato di criticarlo per questo. O qualcuno ha mai storto il naso per le assenze random di Boris Becker, Pete Sampras, Andre Agassi, Roger Federer, Rafael Nadal e Novak Djokovic? Quando hanno voluto-potuto ci sono stati, e tutti hanno vinto almeno una volta l'Insalatiera. Nei loro Paesi sono ricordati e ringraziati (anche) per questo, non certo per aver saltato decine di match. Chi critica Sinner, questo, sembra averlo dimenticato. Critiche che mirano alla pancia e che ignorano un appiglio regolamentare che nessuno (per convenienza? Insipienza? Ignoranza?) ha ricordato: secondo l'articolo 19 del Regolamento di Giustizia FITP, chi dice no alla convocazione in una rappresentazione nazionale, è punito con una sanzione pecunaria e una sanzione inibitiva fino a un massimo di un anno.
Ma c'è di più: il comma 3 dello stesso articolo punisce allo stesso modo i tecnici che allenano od assistono atleti che abbiano rifiutato la convocazione nelle selezioni nazionali ed abbiano ricevuto una sanzione disciplinare definitiva. Capito? In virtù del rifiuto ad andare a Bologna, gli 007 della Procura Federale avrebbero dovuto aprire un fascicolo a nome Sinner, interrogarlo e mandarlo a processo presso il Tribunale Federale, che avrebbe avuto facoltà di squalificarlo per un periodo fino a dodici mesi, salvo la possibilità di appello. Ma c'è di più: avrebbe rischiato lo stesso iter il coach Simone Vagnozzi (mentre non potevano fare altrettanto con Darren Cahill, che non ha alcun legame con la federazione italiana: sembra una barzelletta, ma è così). Tale regola sembra paragonare la convocazione in Davis (e a qualsiasi altra competizione a squadre) a una sorta di chiamata alle armi, equiparando un rifiuto a una diserzione. Non si può che applaudire la scelta della federazione di lasciar perdere (Angelo Binaghi ha addirittura detto di condividere le ragioni che hanno portato al “no” di Sinner, salvo poi aggiungere che dovrà arrivare il momento in cui Jannik dovrà restituire alla federazione, pardon, alla nazione e agli appassionati, i privilegi che sta avendo adesso), ma è chiaro che si tratta di un'evidente mancata applicazione di una norma in vigore. D'altra parte, la storia recente di Davis e BJK Cup racconta come questa norma venga richiamata a intermittenza: dal pugno duro per Bolelli (2008) e Giorgi (2016), fino alla morbidezza per Schiavone, Pennetta, Errani e Vinci e – adesso – per Sinner. Detto che tale norma ci pare anacronistica e sarebbe auspicabile una sua abolizione, è il principio a essere sbagliato. La Davis – in virtù di quanto raccontato nella prima parte di questo articolo – dovrebbe essere vista come una grande occasione, un privilegio, qualcosa di bello, per cui combattere per esserci. Ci sembra che invece venga presentata come un obbligo morale, una chiamata alle armi, un mettersi in riga. E se si viene obbligati a sposare un ideale, probabilmente quell'ideale è sbagliato. Non dovrebbe funzionare così. Sinner? Dovremmo essere felici quando c'è (e speriamo che ci sia a Malaga) e lasciarlo in pace quando ha altre priorità. Come fanno in tutto il mondo.
Ecco, magari facciamogli capire cos'è la Coppa Davis.

Ti potrebbero interessare anche...