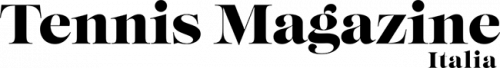La voce del tennis spiegato al popolo
La voce e la passione di Gian Piero Galeazzi hanno incarnato il racconto del tennis in casa Rai dagli anni Settanta all’avvento del digitale. Nel suo "L’inviato non nasce per caso", appena uscito per i tipi di Rai-Eri, ha dedicato un capitolo al suo amore più difficile, il tennis. Dagli esordi accanto a Guido Oddo alla rivalità con i professori Tommasi e Clerici, e le indimenticabili maratone parigine con Adriano Panatta.
Federico Ferrero | 23 febbraio 2016 |
La definizione più asciutta è dell’acerrimo amico – e non è un refuso – Rino Tommasi, un tipo dall’onestà spietata: «Nel tennis è un ruspante. Ma capisce lo sport, ed è una dote preziosa». Gian Piero Galeazzi ha incarnato corpo, voce e adenoidi del tennis in casa Rai per trent’anni; suppergiù, fino a quando la tivù a pagamento sfilò definitivamente gli Slam alla rete pubblica, che peraltro aveva preso a farne un uso sciagurato, specialmente dopo la fine dell’era Panatta (1). Succube della lottizzazione politica e delle scelte dissennate di direttori pallonari, uno Slam finiva triturato dall’intervista al sottosegretario e dai gol della Sambenedettese; manco il tennis si potesse servire un tanto al chilo e poi tagliarlo come il salame, anche sul 5 pari al quinto set. «Ricordo bene quando lo venni a sapere: ero a Flushing Meadows per gli Us Open. Il responsabile dei diritti televisivi, che si chiamava Jim Bukata, mi disse che il torneo se l’era comprato Rete Italia, una società di un certo Silvio Berlusconi. Pensai fosse un errore, non ci volevo credere. Invece era proprio così». Lo sport in tivù stava traslocando.
In un costante rimpallo tra genialità e romanesca, consapevole trasandatezza, la lettura di L’inviato non nasce per caso (Rai-Eri) è una gustosa retrospettiva sulle conquiste, le nostalgie e sì, pure gli eccessi del commentatore tennistico italiano più popolare nell’era analogica. Un racconto che aiuta a rendere verosimile la figura romantica di un cronista verace, da tribuna e marciapiede, molto più della suggestione del satiro Bisteccone, consacrato al trash-pop da Mara Venier a Domenica In. «Che poi, quello è un falso storico: non fu Mara a darmi il soprannome che oggi usano in tanti, ma Gilberto Evangelisti del Giornale Radio Rai. Quando mi presentai, giovane, alto, grosso, ex campione di canottaggio, mi guardò e disse ai colleghi di stanza: “Aò, ma chi è ‘sto bisteccone?”». Gian Piero soffrì per quella svolta, ancorché volontaria: ricorda ancora la copertina del Radiocorriere che lo raffigurava sotto la domanda “Giornalisti o giullari?”. Il varietà gli regalò prebende e popolarità ma gli tolse ruoli e considerazione nella redazione sportiva, dove venne osteggiato da parecchia gente, Marino Bartoletti in testa: «Tutto mi tolsero, pure la sedia. Quando tornai a fare sport, in redazione mi avevano levato pure il posto a sedere».
Provate a scovare un over 35 italiano, mediamente appassionato di sport, cui sia riuscito di scordare le dirette-fiume della premiata ditta Galeazzi&Panatta, quando mamma Rai tentava il gioco impossibile di inserire nei palinsesti uno sport senza scadenze fisse e triplicava le scorte di Optalidon nei cassetti dei caporedattori. Per chi è nato con il telefonino in tasca, è difficile da spiegare. Altro che tweet, alta definizione, dirette multicampo. In un suo celebre sketch, Teo Teocoli era arrivato a presumere che Gian Piero e Adriano, stretti in una cabina del Roland Garros dolorosamente angusta per due pesi massimi, avessero montato un fornelletto da campo per sopravvivere alle sette ore di trasmissione quotidiana, cuocendo uova e fagioli: novelli Bud Spencer e Terence Hill, traslati dal Wild West al centrale di Parigi. «E questa è (bb)bella!», irrompeva Gian Piero nei salotti di mezza Italia all’ora del tè, quando la meravigliosa Gabriela Sabatini stremava di tagli e tocchetti Monica Seles, o Alberto Mancini giocava il suo passante stretto di dritto «di polso: il colpo che preferisco, dopo il whisky del ’69». Tra rantoli e sospiri nel microfono, un sottofondo che si fece familiare e rassicurante per ogni tele-tennis-dipendente dell’epoca, i terraioli del Foro alzavano al cielo l’ennesimo candelone e Gian Piero non ci pensava proprio, a competere con lo Scriba Clerici nel renderli letteratura. Eppure sapeva appassionare. Anche con tre parole, difficilmente ispirate da Voltaire. «Diavolo d’un Chang!», urlò in eurovisione, quando il cino-americano servì da sotto a sua maestà Ivan Lendl negli ottavi di finale dell’edizione 1989 e ne sbriciolò, con quella beffa da circolo, l’ego ipertrofico.


«La sfida inderogabile con Rino Tommasi, a Calcutta, si giocò su un campo limitrofo al centrale, fatto in erba con l’apporto di materiale organico di origine animale. Il primo set volà via in pochi minuti, Rino era completamente padrone del gioco. Allora Clerici, suo mentore e compagno di vita e vizio tennistico, mi suggerì di ritirarmi […] Cominciai a palleggiare, Tommasi prese ad accusare il caldo e vacillare. Non so come, alla fine ci stringemmo la mano senza capire chi fosse il vincitore o lo sconfitto. Fu decretato match pari: mai visto in una partita di tennis, a Calcutta sì»
L'inviato non nasce per caso
Coppa Davis 1990: Paolo Canè infila Mats Wilander e poi muore. Per dieci secondi
Il tennis e le sue pertinenze, i codici, le funzioni parareligiose: per un giornalista estraneo alla intellighenzia snob del settore, per giunta privo di esperti in azienda che lo potessero scolarizzare, erano terra di conquista, ma anche un’insidia. Nel capitolo dedicato alla racchetta, Galeazzi lo spiega con efficacia: «Non è stato facile imporre il mio stile, la mia personalità di telecronista in un ambiente poco disponibile ad accettare le novità, con le sue forme maniacali, le sue leggi, la sua letteratura». Ammette di «aver capito tardi» uno sport lontano dal suo retroterra; per lui, ancora oggi, i riti di una disciplina di fonte aristocratica sono «forme maniacali» e non cultura da preservare. Ma – ciò che conta – ha finito per innamorarsene e, soprattutto, per riuscire a trasmettere su onde captabili dall’italiano medio uno sport elitario per definizione, settario nell’estrazione sociale e nei costi, forse eccessivo nei pregiudizi. Almeno, fino all’avvento di Adriano Panatta, il campione del popolo, figlio del custode del circolo Parioli, fuoriclasse nell’anno d’oro 1976 e spalla tecnica ideale, dal ritiro in poi, per le maratone televisive Rai. Con Panatta, Gian Piero ebbe l’intelligenza e l’astuzia di inventarsi un genere nazionalpopolare ma non becero, magari “basso” ma non caciarone, accessibile senza farsi necessariamente Bar sport. Non potevano fare concorrenza enciclopedica alle lectiones di Tommasi e Clerici per gli abbonati Tele+, ma dalla loro c’erano la genuinità, il carisma del campione e il vantaggio della platea. «Sembra strano, ma tra canoa e calcio alla fine è proprio il tennis lo sport in cui la mia personalità si è espressa di più. Anche per la quantità di ore al microfono: ai tempi, i parigini piazzavano come prima partita degli Open un doppio di francesi, alle undici del mattino. Noi staccavamo la diretta poco dopo le 14, il tempo di due panini e un bicchiere di vino. Che era gratis, quindi ci stavamo attenti. E poi di nuovo dentro, fino a sera». Anche se il sospetto che qualche caloria extra entrasse nel pomeriggio, prima del taglio tassativo delle 18:45 per il telegiornale, si faceva evidenza sgranocchiata.
Tuttavia il Galeazzi mitizzato dalle dirette-fiume dell’Open di Francia, rinchiuso in postazione agli arresti domiciliari del Bois de Boulogne, col tavolo prenotato e il pensiero rivolto alle aringhe con patate della brasserie Le Pichet, non è nato a Parigi ma sul Tevere, al Foro Italico. Ed è il titolare di un’idea strepitosa, viva ancora oggi. «Proprio così. Noi trasmettevamo il match serale di Roma in differita, all’una. Un giorno dovevo lanciare la solita partita notturna, con telecronaca nuda e cruda: decisi di… lanciarla un po’ più in là, diciamo verso il fiume. Non lontano dal campo centrale c’era uno sponsor, la Kim, che radunava i suoi amici intorno a un bicchiere e a un panino. C’era tutto il sottobosco televisivo, bazzicavano pure attori famosi, Gassman, Tognazzi. E allora mi venne in mente di collegarmi per dieci minuti prima della partita da là, dal piazzale del Foro: e dire che c’erano due ombrelloni di numero, forse mezzo divanetto e stop. Era un azzardo. Il regista Mario Conti, però, mi diede retta: allungammo i cavi e presi a intervistare la gente. Chiedevo alla tipetta se je piaceva il tennis, stupidaggini, cose così. Sembrava La Grande Bellezza. Finì che molta gente comprava il biglietto del Foro non per le partite, ma per starsene nell’area vip». E la bellezza diventò enorme ricchezza: il pass per il villaggio ospitalità del Foro Italico prese a essere uno degli status symbol italiani di primavera, lungo tutti gli anni Ottanta e Novanta, «e l’affare della vita del manager Cino Marchese, che capì al volo l’occasione e finì per vendere gli stand a cento milioni di lire a botta».
Se la Roma del tennis, da provinciale e secondaria, diventò adulta, è anche merito suo, di Bisteccone. «Eppure fanno finta di scordarselo: neanche un biglietto di ingresso, un invito. Né a me né a Tommasi, il RinoCeronte. Era una forza, Rino: dovrebbero fargli un monumento. Ricordo ancora i litigi con Panatta, che – pure lui – diserta il Foro da anni: l’ho interpellato per sapere quanto durerà ancora questo stillicidio con la federazione. Mi ha detto che la questione si risolverà quando uno dei due non ci sarà più, e così sia».
Se il commento del tennis in Rai si condiva all’amatriciana, Rino e Gianni, l’altra faccia della luna, creavano arte sportiva sulle reti private. “Gianni e Rinotto”, come li sbertucciava Gian Piero, avevano un torto su tutti: rubacchiare spettatori alla Rai trasmettendo da Telecapodistria, tivù slovena che irradiava su frequenze italiane e, a differenza del Moloch Rai, non violentava il tennis levando la linea sul 5 pari al quinto set per omaggiare il decreto del governo Craxi. Sicché Galeazzi, ai tempi titolare di una rubrica sul mensile specializzato Il Tennis Italiano, non gliele mandava a dire: «Capodistria, che trasmette i gridolini di Clerici e Tommasi mentre noi diamo la linea al Tg, è una tivù simpaticamente pirata». I due cronisti, per conto loro, avevano gioco facile a burlarsi non tanto del giovane e talora grossolano nuovo inviato Rai, quanto del suo anziano tutore: Guido Oddo, sobrio e tiepido accompagnatore del trionfo di Davis in Cile del 1976. Oddo, col rispetto dovuto a un senatore, non era baciato dal dono dell’ars commentandi, né praticava la disciplina. Insomma, ne sapeva poco. Tanto che si ritrovò appioppato l’appellativo dissacrante di DisGuido e fu vittima di una serie infinita di derisioni, dalla vicenda dei calzini dei Pampulov in giù (2), che Galeazzi non perdonò mai ai suoi rivali. «Perché Guido era gran signore, un giornalista vecchio stampo. Io ero un ennecì da Coppa Italia, di quelli che soffrivano in campo, insomma, almeno avevo vissuto le sensazioni del giocatore e me la cavavo. Lui no, conosceva poco il tennis. La sua passione era la lirica, aveva l’abbonamento all’Arena di Verona. La sola telecronaca che poteva fare agli Internazionali di Roma, poi, era quella dall’una alle tre: perché arrivava da casa a Fregene e, prima, si fermava in spiaggia a prendere il sole. Aveva altri tempi, era di un’altra epoca. E così Tommasi e Clerici, che io chiamavo gli eunuchi del tennis, non gliene facevano passare una, davvero: lo distrussero». Anche con Panatta non c’era buon sangue: «Una volta Adriano, a mezza bocca, disse a Rino: “Aò, ma che vòi, tu che giocavi a San Benedetto del Tronto?”». Era la sfida dei laureati contro gli illetterati.

Gian Piero Galeazzi al microfono con Adriano Panatta, e in compagnia di John McEnroe
L'inviato non nasce per caso
Un giovane Gian Piero Galeazzi intervista Nicola Pietrangeli, prima della finale di Davis del 1976
Le pagine di L’inviato non nasce per caso, cotte e da mangiare nello spirito di una sua telecronaca, si alimentano di un sentimento di nostalgia non solo per un capitolo forse chiuso per sempre – l’adozione del tennis da parte di mamma Rai – ma soprattutto per un mestiere estinto: il giornalista sportivo viaggiatore, che rimane ustionato dal sole di Calcutta mentre Ramesh Krishnan si cucina la nazionale di Davis con il curry o che si immola a Maceiò ‘92, accanto alla trombetta molesta del capotifoso D’Artagnan. E che, dopo una settimana di entrecôte e patate duchesse, vaga disperato alla ricerca di un’insegna tricolore per avventarsi su pasta e polpette al sugo. «Il tennis sulla Rai? Dico che lo abbiamo perso un po’ per incuria, un po’ perché mancavano campioni italiani. Eppure mi ero inventato personaggi esteri da tifare, Becker Bum Bum, Edberg Tacchino Freddo. Che poi, lo svedese lo chiamavo così solo per andare contro Tommasi, che era un suo tifoso, e allora dicevo “Ma dddai, ‘sto mezzo frocetto che nun vince mai…”».
Un quarto di secolo di presunto progresso e i telecronisti di oggi lavorano fissando due schermi in un cabinotto, con le valigie a far muffa in cantina. Quelli di Galeazzi erano anni di lavoro più artigianale, e pure di disinvolture oggi inconcepibili: «Ma c’era più fascino, indubbiamente. Una fermata d’obbligo a Wimbledon, per esempio, era il betting office di Gloucester Road: una anno, Panatta mi aveva convinto a scommettere tutto su Lendl». Invece il 1987 fu l’edizione della scalata alle tribune di Pat Cash, e il racconto del rientro in sede agevolato da un prestito per mano del mitologico corrispondente da Londra, Sandro Paternostro, è una piccola gemma. Ai tempi, puntare sulle partite non era un divieto da sanzione disciplinare ma un passatempo diffuso e condiviso: «Una volta, John Newcombe in persona venne a dirci che McNamara e McNamee avevano prenotato il volo di ritorno per la sera, non so se mi spiego». Perfettamente: gli australiani erano una delle coppie più forti del mondo e non avevano intenzione di passare il turno. Oggi, sarebbe materia da Tennis Integrity Unit; ieri, niente più che un gioco per arrotondare e, se funzionava, arricchire la cena di una bottiglia “giusta”. E andava bene così a tutti.
Gian Piero Galeazzi ha staccato lo spinotto del microfono nel 2011. Gli piacerebbe essere chiamato per la finale degli Internazionali, come voce storica. «Di colore», dice lui, che non ama la cronaca asettica e ragionieristica. Il suo rammarico professionale più difficile da buttare giù è l’aver avuto trent’anni di tempo ma mai l’occasione di commentare una finale dello Slam giocata da un italiano. «Ore, ore, ore di commento e mai una volta. Ho smesso io, è arrivato Fabretti che in un quarto d’ora si è fatto la Schiavone a Parigi e la Pennetta a New York. Mavva’… L’unica finale importante, quella di Coppa Davis in Cile nel 1976, la dovemmo fare dall’Italia perché il governo Andreotti ci costrinse a stare a casa e a trasmettere le partite in differita per protesta contro il regime: partirono tutti, quelli della radio, pure nani, ballerine, tric e trac, anche i magazzinieri. E noi a Roma». Già, il regime di Pinochet, la battaglia di Pietrangeli per evitare il boicottaggio. E Guido Oddo che, come si direbbe oggi, fece da clamoroso spoiler durante la differita del doppio: non si trattenne e annunciò il successo dell’Italia mentre la gente, allora sprovvista di Internet e di comunicazioni dirette con l’altra parte del mondo, era ignara del risultato e si ritrovò la festa rovinata. «Non puoi capire le telefonate: i centralini di via Teulada scoppiavano di chiamate, telespettatori infuriati, fummo costretti a chiedere scusa. I centralinisti ci dicevano: “Aò, ma che avete detto? Che ha perso la Democrazia Cristiana?”».
La sua storia scritta racconta, con passione e nostalgia autentiche, la strada di un ex canoista che, parole sue, finì per farsi prendere dalla foga del fare e dell’andare, malattia cronica dell’inviato, e scordò l’ufficio. Non fosse stato per Fabrizio Maffei, avrebbe chiuso la carriera in Rai senza neppure uno scatto di qualifica: «Si interessò lui per farmi diventare caporedattore». Aggiustando stipendio e pensione.
Gran tifoso della Lazio, per lo scudetto del 2000 si macchiò del reato di abbandono di cabina: sloggiò, come racconta nel libro, dalla diretta della finale Norman-Kuerten per trasferirsi appena più in là, seguìto a ruota dalla troupe, per tuffarsi nella bolgia dello stadio Olimpico.
Il suo ingresso nel club erremosciato del tennis avvenne con passaggi poco ortodossi: le sue pronunce talora faticose, le regole difficili da mandare a memoria, qualche inevitabile svarione. Eppure venne ammesso, apprezzato, amato e infine rimpianto, perché tutti riconobbero che Gian Piero Galeazzi si era inventato un genere: un racconto del tennis facile ma tutt’altro che ignorante, forse grezzo ma di talento. Quando Paolo Canè vinse il punto della vita, in Coppa Davis, contro Mats Wilander a Cagliari nel 1990, Bisteccone lo guardò gettarsi a terra stremato e, poi, scollarsi dalla terra, dragato dai braccioni di capitan Panatta. Ispirato da chissà quale Musa, recitò l’epigrafe di un momento storico: «E poi morire, per dieci secondi». Se questa non è classe.
PS. La Federtennis, nel 2006, ha istituito un premio giornalistico intitolato a Guido Oddo. Meritevoli del riconoscimento, attribuito dall’ufficio stampa interno: Gianni Clerici (2006, non ritirato); Dario Torromeo (2007); Ubaldo Scanagatta (2008); Piero Valesio (2009); Roberto Lombardi (2010, alla memoria); Roberto Perrone (2011); Gianni Valenti (2012); Stefano Meloccaro (2013); Vincenzo Martucci (2014); Mario Viggiani (2015).
(1) La Rai, finita la febbre del tennis verso la fine degli anni Settanta, prese a trascurare il tennis, arrivando a non trasmettere Wimbledon pur detenendone i diritti. Quando Silvio Berlusconi, socio di Tele+, “girò” i diritti del torneo alla rete a pagamento, scoppiò il finimondo: Agassi vinse il torneo, Tele+2 oscurò l’avvenimento ai non abbonati e la Rai reagì. Sua opinione era che il diritto all’informazione venisse leso, se a tutti i cittadini non fosse stata offerta la possibilità di seguire i grandi avvenimenti sportivi in chiaro (anche se la stessa Rai, per anni, ne aveva fatto scempio o li aveva ignorati). Il vicepresidente Rai di allora, Leo Birzoli (di area socialdemocratica) disse: «Sarebbe ingiusto che manifestazioni sportive di grande interesse popolare fossero affidate a sistemi discriminanti come la pay tv. Non si possono separare gli sport dal pubblico solo perché qualcuno spera di costringere la gente ad abbonarsi alla sua tv a pagamento». Il grande vignettista Vincino dedicò una vignetta alla vicenda, sul Corriere della sera. Erano gli albori della specializzazione della tivù: sarebbe arrivata RaiSport, Eurosport avrebbe presto aperto la versione italiana del suo canale (inizialmente, tra l’altro, prendendo a prestito telecronisti Rai in congedo, compreso Guido Oddo) e il tennis avrebbe trovato il suo spazio, fatalmente nemico dei palinsesti generalisti per la sua durata incerta, su reti a pagamento dedicate allo sport.
(2) Durante un Italia-Bulgaria di Coppa Davis del 1973, allora tramesso in bianco e nero, Oddo manifestò a più riprese la sua frustrazione per l’impossibilità di distinguere i gemelli Bozhidar e Matei Pampoulov, impegnati in un match di doppio, e finì per chiedere in diretta di far indossare loro calzini di colore diverso, o un segno distintivo sulla maglietta. Solo allora gli fecero notare che uno era mancino, l’altro destrorso. Pare che l’appellativo DisGuido, coniato da Gianni Clerici, sia nato in quel frangente.

Ti potrebbero interessare anche...