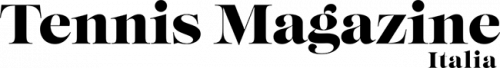La mia prima volta
Uno dei più apprezzati inviati del Corriere della Sera, fanatico tennista, ricorda il suo esordio a Wimbledon: «Perché ci sono momenti in cui realizzi quel che avresti sempre dovuto sapere»
Marco Imarisio | 27 giugno 2021 |
La prima volta è arrivata dopo 47 anni di attesa. Dopo figli, lavoro, trasferte di lavoro, altro lavoro. Al netto di queste incombenze e tolti gli anni dell'infanzia, ma proprio i primi 5-6, è quasi una vita intera da spettatore, più divano e televisione che tribuna stampa, perché purtroppo nel giornalismo mi occupo di altro. Nella primavera del 2014 il capo della redazione sportiva del Corriere della Sera mi fermò nel corridoio per dirmi che la collega titolare del tennis quell'estate sarebbe stata inviata al Tour de France. E certo, continuò, ci sono i Mondiali di calcio, ma qualcuno a Wimbledon bisognerà pur mandarlo, anche se non ci sarà tanto da scrivere, ti farebbe piacere? «Ma figurati, se serve al giornale... » risposi dandomi un tono, e incassando persino un grazie, accolto con una scrollata di spalle. Lo guardai allontanarsi, resistetti fino a che non entrò nell'ascensore. Poi incominciai a ridere, ma solo perché non potevo correre ed esultare per le sacre stanze di via Solferino come Tardelli dopo il gol nella finale dei Mondiali di Spagna.
Ci sono momenti in cui realizzi quel che avresti sempre dovuto sapere. Quella vita da guardone professionale, la progressiva costruzione di una ossessione che in età matura avrebbe assunto forma e consapevolezza definitiva, al punto da non provare più vergogna di me stesso per i pomeriggi interi passati a guardare in streaming improbabili secondi turni di futures slovacchi o ignobili partite di circolo con giocatori persino più scarsi dello scrivente, ha sempre girato intorno a una parola. A un suono, ormai onomatopeico. Wimbledon. Pronunci quella parola e ti scorre davanti non un film, ma la poesia del tennis, perché la poesia è quella cosa con dentro tutte le altre che ci tengono in vita, e Wimbledon contiene in sé quel che di più bello e nobile rappresenta questa tremendo gioco con le palline gialle che ci fa uscire pazzi. In un altro articolo di qualche anno fa ho provato a raccontare cos'è Wimbledon per me, nel senso della persona. Uno dei miei primi ricordi da bambino è un televisore in bianco e nero, le immagini storte, o rese tali dal febbrone che mi divorava nella stanza di un residence a Numana, mentre mio padre, con la scusa del figlio malaticcio, guardava la prima delle cinque, ovvero Borg-Nastase, 6-4 6-2 9-7. Almeno così credevo.


Gli anni ruggenti di Wimbledon, tra il 1978 e il 1999
Quando gli feci leggere l'articolo in questione, il pater familias sospirò. «Cretino, era il 1974, avevi 7 anni, tu deliravi per una infezione alimentare e io guardavo Connors-Rosewall, in differita per altro». Le finali di Wimbledon hanno scandito le mie estati, quindi la mia vita. Ricordo dov'ero quando Borg si inginocchiò dopo l'ultimo passante di rovescio contro Mc Enroe, ricordo dov'ero all'epifania di Boris Becker, alla crudele vittoria di Michael Stich, al suicidio di Patrick Rafter, e poi Sampras, Roger, e via risalendo. Non esistono nello sport luoghi tanto evocativi come lo è Wimbledon. Saranno gli inglesi, che sono bravissimi a vendere la propria storia. Sarà il luogo, persino la parola, che mi piace tantissimo e quindi la scrivo ancora, Wimbledon, chissà quanti sanno che sarebbe anche il quartiere, molto bello, dove si trova l'All England club, dove si gioca il torneo di tennis più antico del mondo. Ma c'è qualcosa di mistico, in quei viali, in quel centrale adornato all'esterno da un'edera maestosa che sembra stare lì dai tempi di Tilden, nei volontari anziani, quasi decrepiti, vestiti con la divisa sociale, con il calzino a coste intonato alla giacca verde. In quei cancelli che si aprono il primo lunedì di luglio, e sono davvero cancelli, i Doherty Gates, in quella scritta argentea sotto alla quale passano i giocatori che entrano sul centrale, la vittoria e la sconfitta, due impostatori, da Kipling.

A Wimbledon si respira un'aria particolare, quasi mistica
La finale di Wimbledon 2019, raccontata come inviato da Marco Imarisio
Ci ho messo un po' per capire. E alla fine mi è capitato in sorte di raccontarne una, di finale. Molto bella, per altro. Ma prima ho fatto gli sbagli dell'esordiente, uno dei tanti. Il primo giorno, ho preso il taxi per andare a Wimbledon. E appena ritirato l'accredito, mi sono fiondato sul centrale, quasi che potesse scappare da un momento all'altro, spostarsi e non tornare mai più, per impedirmi di dire io c'ero, o meglio, ci sono stato. Non uno, ma due errori. Wimbledon è tutto quel che c'è intorno. Bisogna prendere la metropolitana. Scendere a Southfields. Se guardando quella banchina spoglia, con poche panche poco frequentare, sentite già qualcosa di evocativo, siete a casa. La risalita di Church road va fatta ogni giorno, guardando ai lati, quell'intrico di vie così tipiche, così vecchia Inghilterra, quell'alternanza di facciate bianche e èprati verdi. Una volta dentro, fate il periplo del centrale, senza entrarvi. Wimbledon è nei dettagli, nel tabellone compilato a mano, nei campi verdi allineati e separati uno dall'altro da un cordoncino e da una stretta passerella di ghiaia, dove uno è uguale all'altro, l'ultimo neofita e il più grande di sempre, così vicino che potresti toccarlo. Bisogna respirarlo a pieni polmoni, Wimbledon, tenendo gli occhi chiusi, sentendone l'odore. Solo allora capisci perché i giocatori qui dentro si sentono parte non di una storia, ma della Storia.
Io ci sono arrivato all'ultimo. Era finita la finale, Djokovic aveva battuto Federer al quinto. Cadde una pioggia intensa e breve. L'All England club si stava svuotando. I campi laterali splendevano, l'odore dell'erba riempiva l'aria. Si respirava anche una malinconia diffusa, che sembrava avvolgere Wimbledon, gli steward cortesi, persino noi giornalisti. Nell'articolo attribuii questa sensazione alla consapevolezza del fatto che ancora mancava poco, ancora qualche bagliore e poi non avremmo più rivisto Federer. Mi sbagliavo, ancora una volta. È qualcosa di più intimo, di più profondo, che appartiene al luogo. Quando finisce Wimbledon, sai che c'è da aspettare non qualche mese, ma un anno intero. Sai che quei cancelli si riapriranno soltanto la prossima estate. Non c'è nessun’altra cattedrale che ti faccia sentire così. Wimbledon è davvero il Vaticano del tennis. Ma fidatevi, cominciate a guardarlo da lontano. Non fate come me. Prendete la metro, salite a piedi sulla collina.