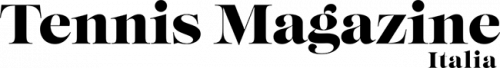Un Essere Umano nella Terra degli Dei
Sfidando la progressiva decomposizione del suo corpo, Andy Murray ha giocato ben oltre il limite del lecito. Ma la sua etica del lavoro andava oltre il concetto di vittoria e sconfitta: per questo, ha saputo reggere per dieci anni il ritmo degli extraterrestri. Lascia sapendo di aver vinto tutte le sue battaglie, anche le più subdole.
Riccardo Bisti | 5 luglio 2024 |
“Vorrei giocare per sempre”. Ha detto così, e la scelta linguistica deve essergli costata moltissimo. Avrebbe voluto dire "voglio", ma Andy Murray è costretto a ritirarsi. “Quest'anno è' stato troppo duro – ha detto, dopo il sontuoso tributo che gli hanno riservato sul Centre Court – c'è stata la caviglia, l'operazione alla schiena, ovviamente l'anca... Sono pronto a smettere perché non riesco più a esprimere il livello che vorrei. È qualcosa fuori dal mio controllo. Se sapessi che il mio corpo è in grado di andare avanti, giocherei. Ma so è che è arrivato il momento. Sono pronto”. Arrendersi all'evidenza può essere molto doloroso, ma allo stesso tempo gli permette di lasciare senza rimpianti. Le ha provate tutte. Ha aspettato fino all'ultimo secondo utile, nella speranza di giocare in singolare.
Niente da fare. E allora ha scelto il doppio con il fratello Jamie per salutare, vero commiato prima del giocoso addio in doppio misto, nel quale farà coppia con Emma Raducanu. Ci hanno pure provato, lui e Jamie, contro Peers-Hijikata. “Ma il mio servizio e tutto il resto sono troppo indietro rispetto a dove dovrebbero essere”. Ci sono stati momenti, durante la partita, in cui abbiamo avuto la sensazione che gli si staccasse un pezzo. Sembrava messo insieme con lo scotch, un rottame tennistico che ha artificialmente allungato di cinque anni la sua carriera. “Artificiale” è il termine giusto, vista l'anca di metallo che si è fatto impiantare nel 2019, dopo che aveva già salutato tutti all'Australian Open. Ha continuato a giocare scrivendo qualche pagina di epica, sia pure a distanza di sicurezza da quei tre signori per i quali ci ha rimesso la salute. Pur di restare al loro ritmo, ha consumato il suo corpo fino a devastarlo.
-
1.122
Le partite giocate da Andy Murray, con un bilancio di 832 vittorie e 290 sconfitte. La prima risale al Challenger di Manchester nel 2003, l'ultima è il ritiro contro Jordan Thompson al Queen's. Ma alle Olimpiadi ne giocherà almeno un'altra.
La definizione più corretta di Andy Murray l'ha data Jonathan Liew, sull'Independent, ai tempi del suo primo ritiro: ”Un Umano nella terra degli Dei”. Non aveva la tecnica di Federer, non è stato un fenomeno di resistenza come Rafael Nadal, e nemmeno dotato del fisico sovrumano di Novak Djokovic. Però aveva cuore, intelligenza e un desiderio sfrenato che gli ha permesso di restare a galla nell'epoca più dura nella storia del tennis. Ha battuto per ben 29 volte i suoi principali rivali, intascando 46 titoli. Ha vinto soltanto tre Slam, ove la parola soltanto pesa come un macigno. Nella goliardia calcistica, chi non ama la Juventus ricorda sempre che i bianconeri hanno vinto soltanto due Champions League, “tante quante il Nottingham Forest”. Si può estendere il discorso a Andy Murray e Stan Wawrinka, con lo svizzero capace di fare tre come lui. Ma sarebbe ingeneroso paragonarli. Andy ha vinto il triplo dei tornei ed è stato molto più continuo, sublimando la superiorità con il raggiungimento della prima posizione mondiale, mentre lo svizzero non è mai andato oltre il numero 3. Pensando agli ultimi vent'anni di tennis, si è dibattuto molto sulla nomenclatura: era giusto parlare di Fab Four (termine coniato nel 2008) oppure limitarsi a Big Three? A costo di sembrare democristiani, la nostra risposta è un ibrido: abbiamo assistito all'epoca di 3 Grandi + 1. Perché Murray non è stato all'altezza degli altri tre, ma non lo si può paragonare a tutti gli altri.
È stato l'unico essere umano che ha provato a restare al ritmo di tre extraterrestri, riuscendoci per una decina d'anni prima che il motore si fondesse. Lo sforzo di tenere il passo con la più grande generazione di sempre è stato talmente grande da decretare la rottura. Quel che è successo dopo – gli ultimi anni di trascinamento agonistico – ci hanno fatto conoscere meglio il Murray persona, al punto da spingere qualche media britannico a sostenere che sia stato un grande campione, certo, ma una persona ancora migliore. Gli ultimi anni ci hanno permesso di guardare con occhi diversi la prima parte della sua carriera, una continua lotta con se stesso e contro il resto del mondo. Senza tornare al massacro di Dunblane (i cui ricordi nella sua mente – secondo noi – sono stati più vividi quando ha vinto l'oro olimpico nel 2012, con quel commovente sguardo verso il cielo), gli avevano diagnosticato una frattura della rotula quando aveva 17 anni, dicendogli che non avrebbe mai giocato ad alti livelli. Quell'episodio ha forgiato una delle sue caratteristiche principali: la capacità di giocare con il dolore, sublimata da una partita che pochi ricordano, contro Jerzy Janowicz in Coppa Davis. Aveva un infortunio al polso e non era il caso che giocasse, ma con la Gran Bretagna sotto 2-1 si piegò alle pressioni del capitano e dei compagni di squadra. Vinse, ma fu inutile. La Gran Bretagna perse ugualmente e lui aggravò il problema.

Andy Murray è nato a Dunblane, in Scozia, il 15 maggio 1987
Probabilmente hanno ragione quando dicono che è una bella persona. Noi lo abbiamo compreso qualche anno fa al Foro Italico, quando si avventurò in una zona aperta al pubblico completamente da solo, senza guardie del corpo. A Roma non lo fanno neanche i giocatori di seconda fascia. In pochi secondi fu attorniato da bambini a caccia di foto e autografi, ma non fece una piega. In Gran Bretagna lo capirono in occasione di quel già citato match di Davis, in cui si piegò alle richieste della LTA, lo stesso ente che qualche anno prima lo aveva ignorato quando vinse lo Us Open junior. Era il 2004 e il responsabile della comunicazione tornò a Londra dopo l'eliminazione di Tim Henman, trascurando lo scozzese. Erano gli anni in cui mamma Judy implorava finanziamenti dallo Scottish Institute of Sport, dicendo che il figlio aveva vinto uno Slam junior. “Non ci interessano i campioni junior. Ci interessano i campioni Slam” le risposero. Fu la molla per accendere l'ossessione Slam, ancora più pesante in un Paese di media-pescecani, peraltro in attesa dai tempi di Fred Perry. Perse le prime quattro finali e la maledizione non passava.
E allora scelse di farsi aiutare da chi aveva vissuto lo stesso percorso, Ivan Lendl. Prima trionfò alle Olimpiadi del 2012, battendo in finale quel Roger Federer da cui aveva perso poche settimane prima a Wimbledon, arrivando fino alle lacrime. Poi vinse lo Us Open, stoppando un digiuno di 76 anni. Bello, bellissimo, ma i britannici sono incontentabili. Loro volevano Wimbledon, vedere un Suddito della Regina sollevare finalmente quel trofeo. Per questo i successi del 2013 e del 2016 sono molto di più che un semplice nome scolpito nell'albo d'oro. Costretto a convivere con il soffocante fardello delle aspettative, le ha sapute soddisfare con il suo monumentale sforzo. Ha combattuto da solo le sfide più difficili. Gli avversari non erano Federer, Nadal e Djokovic: erano il peso della storia, un complesso di inferiorità nazionale, lo snobismo dell'establishment del tennis britannico, che lo aveva accolto con diffidenza. Non gli perdonavano la provenienza scozzese, come se potessero pretendere la razza pura inglese. E gli preferivano l'elegante e oxfordiano Tim Henman, uno che non avrebbe mai vomitato sul campo da tennis, e non si sarebbe sognato di scendere in campo a Wimbledon con la barba incolta e i capelli arruffati. Eppure ha vinto Andy.
Tutti ricordano quel pomeriggio del 2013, quando vinse per la prima volta. Ricordano le urla premature quando Djokovic piazzò un primo rovescio disperato sulla linea, e ricordano la sensazione extracorporea quando il rovescio successivo si è fermato sul nastro. In un istintivo impeto di ribellione, lo scozzese si rivolse verso la tribuna stampa digrignando i denti, mentre la moglie Kim Sears si metteva le mani sulla fronte e guardava fissa chissà dove, come se fosse in trance. Un attimo di pura catarsi. E qui torniamo al concetto di essere umano imbucato nella Terra degli Dei: gli altri tre facevano sembrare tutto maledettamente facile, mentre ogni singola partita di Murray ci ha ricordato quanto fosse duro il tennis.
Il suo dolore penetrava nell'anima degli spettatori, tra invettive al vetriolo e urla di sfinimento. Non gli è mai andata giù la mediocrità e ha fatto tutto il possibile per offrire la migliore versione di sé, quello che il suo fisico e il suo talento maledettamente umani gli avrebbero concesso. “Non ho fatto tutto bene nella mia carriera, sono stato ben lontano dalla perfezione – ha detto giovedì sera – ma c'è qualcosa di cui vado orgoglioso: a prescindere da vittorie e sconfitte, ho sempre avuto la stessa dedizione, etica del lavoro e passione del giorno prima. Di questo sono orgoglioso. Spetterà ad altri stabilire quale sarà la mia eredità. Per me è questa”. E chi siamo noi per contraddirlo?