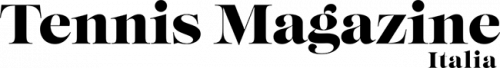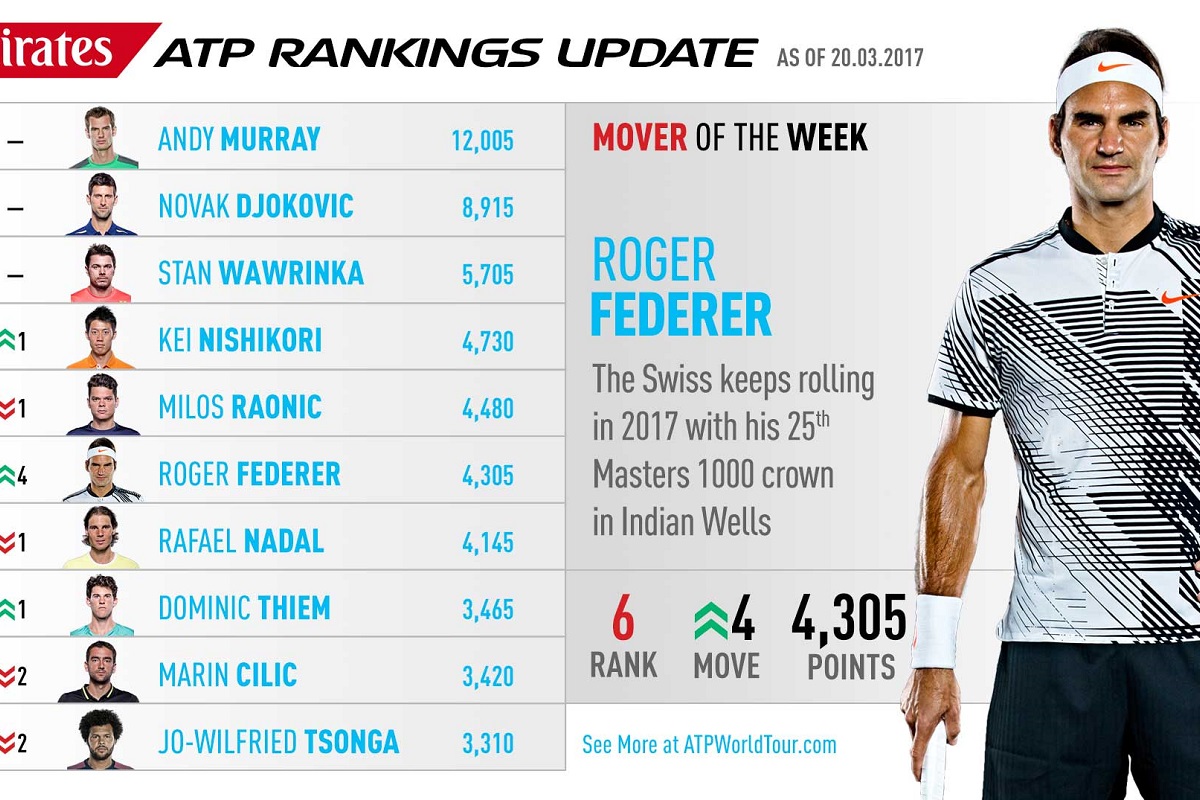Adriano Panatta, l’Ultimo
Marco Bucciantini ha rivissuto con Adriano Panatta quel meraviglioso Roland Garros del 1976. Incontro dopo incontro, dal match point salvato al primo turno a Pavel Hutka fino al successo finale contro il sorcio, Harold Solomon. Nella chiacchierata sono emersi tanti aneddoti, curiosità e quel pensiero leggero e ironico che ha sempre distinto colui che, piaccia o meno, resta il simbolo della storia del tennis italiano
Marco Bucciantini | 9 luglio 2020 |
Parigi, 1976. Questa è la storia dell’Ultimo. Andò così.
Primo turno: Adriano Panatta b Pavel Hutka 2-6 6-2 6-2 0-6 12-10
L’unica cosa certa di un tuffo è il volo. Panatta era stanco e il torneo doveva ancora cominciare. «Roma e Parigi erano in successione, avevo giocato la finale al Foro Italico due giorni prima, quattro set con Vilas (e al meglio dei cinque set si disputò anche la semifinale, che Adriano vinse contro John Newcombe, Ndr). Contro Hutka poi non fu semplice: lui giocava in modo unico, nel senso che mai avevo visto e mai rivedrò un tennista che serve con una mano (nel suo caso la sinistra) e poi colpisce dritto e rovescio con l’altra. Le volée con la destra, lo smash con la sinistra. Si passava la racchetta da una mano all’altra e giocava anche bene. Andò avanti, ribaltai, riposai il quarto set e poi ci fu il quinto, lungo, lunghissimo. A Roma avevo capito di poter vincere uno Slam. Fu un’impressione che misi in valigia nel viaggio per la Francia. Ma lì, in campo, contro Hutka, contro la stanchezza, diventò convinzione».
Molti anni dopo sembra il copione di un film o una favola: qualcosa di suggestivo e ineluttabile, scritto con tanto cuore e con l’amore per i finali perfetti. Quel pomeriggio però, si consumò diverso, più drammatico che sognante. Perché, intanto, eravamo 10-9 per lui, l’uomo che giocava cambiando mano, al quinto set, 30-40, servizio Panatta. Si chiama match point. Adriano va a rete, gestisce un pallonetto con il suo colpo brevettato, la veronica, che in fondo è uno smash con il corpo rivolto al proprio campo, giocato dal lato del rovescio. È difficile, elegante, tecnico, richiede coordinazione e sensibilità: figuratevi con quelle racchette dalla superficie d’impatto ridottissima. Hutka ci arrivò, per piazzare il passante vincente, per battere il vincitore degli Internazionali.
Ma non è questa la storia che conosciamo. È diversa, è unica, è l’ultima che possiamo raccontare e lo facciamo da 42 anni con la stessa testamentaria emozione, per niente affievolita dalla conoscenza, tramandata per essere custodita. Panatta si buttò, lo faceva, se serviva: lo fece anche al Foro, contro Vilas, nel momento decisivo, nel tie-break del secondo set. A Roma, la successione fu inversa: prima il tuffo e poi la veronica, nello scambio che assegnò quel parziale. Due set dopo, la vittoria. A Parigi, dunque: prima la veronica, poi il tuffo. Sulla sinistra, volée di rovescio che cade di là, e non trova nessuno: Hutka non c’è più. Ormai è uscito dalla storia. Si è fermato lì, sul passante. Ha visto, non ha capito, non poteva: 12-10 per Panatta, che va a rete e lo abbraccia con calore. Le immagini dimostrano che è più della cortesia dovuta, più del riconoscimento della lotta. Sembra un ringraziamento del vincitore: mi hai fatto tuffare, e ci si tuffa per volare. Panatta volò. «Qualcosa era cambiato, dentro di me sapevo che potevo vincere uno Slam».
«La rivelazione fu un viaggio in Australia, appena 18enne, che cambiò il mio modo di concepire il tennis. Dividevo il campo con Laver, Rosewall, Roche, Newcombe, Stolle. Fui sedotto dal loro tennis: in pratica, vidi come si doveva giocare» Adriano Panatta
Secondo turno: Adriano Panatta b. Jon Kuki 6-3 6-1 7-5
Ho acceso quel fuoco. «Io giocavo un tennis difficile: traiettorie rischiose, scelte esigenti, spesso definitive. Cercavo colpi dominanti, ma se non arrivavo bene con le gambe non potevo colpire come volevo, sbagliavo di pochi centimetri e non riuscivo a tessere il mio gioco. Altri, come Borg, Vilas, Connors, avevano un tennis con maggiori margini di sicurezza, fatto di tanti colpi interlocutori perché poi si esaltavano nel rincorrere la palla negli angoli. Si fortificavano nella lunghezza dello scambio, nella lotta. Potevo anche io scegliere quel gioco, in fondo sono nato sui campi in terra e sono cresciuto con scambi lunghi, anche se magari insaporiti da quel po’ di talento. Poi successe una cosa che non aspettavo ma forse in qualche modo cercavo. La rivelazione fu un viaggio in Australia, appena 18enne, che cambiò il mio modo di concepire il tennis: i gesti, gli schemi, il senso del campo. Era una trasferta di formazione che ci offrì la Federazione. Ci ospitava quella australiana e potevamo dividere il campo con i maggiori tennisti della storia: Laver, Rosewall, Roche, Newcombe, Stolle. Fui affascinato dalla loro disponibilità umana e fui sedotto dal loro tennis: in pratica, vidi come si doveva giocare. E soprattutto imparai l’importanza del servizio, e il modo di farlo bene. In Italia c’è sempre stata una strana ritrosia nell’insegnare questo colpo. Come se il tennis fosse solo colpire e scambiare. Come se insistere sul primo colpo fosse una riduzione pigra del lavoro. Eppure, oggi la media degli scambi è di quattro, cinque colpi: credo che in Italia si sia spesso sottovalutato l’importanza del primo colpo, assai più decisivo del decimo o del quindicesimo.
Tornai dall’Australia con le idee chiare su cosa dovevo fare per migliorare. Ma laggiù non liberai solo il mio tennis: scoprii anche i The Doors, ascoltai un loro disco, che in Italia arrivò qualche tempo dopo: Light my fire. Un suono, un ritmo, un testo che manifestava al mondo un’esigenza. Era il 1968 e io giocavo a tennis, certe cose mi sfuggivano, ma quella musica mi entrò nel sangue e fu un modo di partecipare alla rivoluzione. Il rock, e più ancora il blues rock: avevo trovato la colonna sonora della mia vita». La vittoria di Roma fu come attizzare quel fuoco. Di Kuki, Panatta non ricorda quasi niente, solo che in campo - in quei giorni - era imbattibile, era un fuoco acceso.
«Il trofeo di Roland Garros l’ho perso. Ero sicuro fosse in soffitta, finché non l’ho più trovato. Chiesi a mia madre se ne avesse avuto traccia e mi rispose semplicemente: boh... Ma credetemi, era una coppetta, il valore sentimentale ce l’ho dentro» Adriano Panatta
Terzo turno: Adriano Panatta b. Jiri Hrebec 7-5 6-3 6-4
Magliette rosse. Ancora un cecoslovacco, come Hutka. Più forte: Hrebec era uno dei due singolaristi della squadra di Davis che pochi mesi prima a Stoccolma aveva perso la finale contro la Svezia di Borg, primo successo europeo dai tempi dei moschettieri francesi e dello squadrone britannico degli anni Trenta. Con Hrebec, c’era Jan Kodes, il maggiore fra i boemi, prima di Ivan Lendl, capace di vincere tre Slam (due volte Parigi, poi Wimbledon). La Cecoslovacchia sarebbe tornata in finale cinque anni dopo, nel 1980, battendo l’Italia e chiudendo un periodo irripetibile per la nostra nazionale, alla quarta finale di quel breve periodo di tempo, da metà anni Settanta in avanti. Fra i cecoslovacchi – appunto – era apparso Lendl, ormai robusto tennista destinato al vertice, e con lui Tomas Smid. Nell’Italia c’era Ocleppo a fare il quarto al posto di Zugarelli. Ma c’era Tonino nella vittoria del 1976. «Eravamo due coppie di amici, io con Bertolucci e Barazzutti con Zugarelli. Ci univa Mario Belardinelli, autorità fatta persona. Non sono mai riuscito a dargli del tu. Parlava poco, solo quando sapeva cosa dire. Diretto, onesto, vero. Era ascoltato come un oracolo. Vedeva questo sport ed era un meraviglioso artigiano di tennisti».
La Cecoslovacchia era il pezzo più tormentato e vivace del blocco comunista. Aveva pagato la voglia di cambiare, era fuoco spento, ma aveva la miglior scuola di tennis e tennisti oltrecortina. La politica s’immischiò anche dall’altra parte del mondo, in Cile, dove finimmo a giocare la finale del 1976 anche per la rinuncia dei sovietici – che non vollero riconoscere il dittatore Augusto Pinochet. Si va. Non si va. Andare significava legittimare il dittatore, non andare mortificare la squadra, gli appassionati, l’idea di sport. E darla vinta al dittatore. «Di quelle storie non me ne fregava un cazzo. Erano anni difficili, estremi, tutti parteggiavano e si sfidavano nel farlo nel modo più partecipe, fanatico, perfino fasullo. Oggi sembra assurdo, forse vivendolo non lo era. Però io in Cile qualcosa volevo fare, un atto di protesta. Dissi a Paolo Bertolucci: mettiamoci la maglia rossa». Rosso è il colore della resistenza al regime militare. Bertolucci disse solo tre parole: «Adriano, ci arrestano».
Sabato mattina, Santiago del Cile. C’è il doppio per chiudere e vincere la Coppa Davis: la prima, l’ultima, perché questa parola ricorre. Per mezzo Paese, essere là era un tradimento a non si sa cosa. Per i ragazzi, era finire un lavoro, per loro stessi, per gli italiani, per dare loro una vittoria che resta ancora unica. Avevano ragione loro. «Adriano, ci arrestano». Ma Paolo si lasciò trasportare dall’amico. «La tv diffuse poche immagini e dai colori virati. In breve: della nostra maglia rossa se ne accorsero 40 anni dopo, quando un giornalista lo scrisse in un libro…». Il doppio fu il punto del 3-0. Vinsero anche per chi non ce li voleva mandare. Erano più forti, era impossibile perdere, era giusto vincere.
Jiri Hrebec presentì la stessa impotenza dei colleghi cileni: non pensò mai un minuto di poter vincere quella partita contro Adriano, che dopo quel tuffo ancora volava.
Ottavi di finale: Adriano Panatta b. Zeljko Franulovic 6-2 6-2 6-7 6-3
Il croato è oggi un manager affermato, prima ai vertici dell’ATP, ora come direttore del torneo di Monte-Carlo, che peraltro vinse da giocatore, come fu anche finalista a Roland Garros, battuto da Kodes. Era un tipo tosto, «sulla terra batteva Vilas, per capirci». Per Panatta era l’ostacolo alla partita che aspettava e desiderava: quella con Borg. Quel pensiero lo distrasse nell’unica partita della carriera che lo agita e lo affanna come succede ai rimpianti. Fu a Wimbledon, nel 1979. «Sull’erba volevo far bene, non mi è riuscito quasi mai. La critica ha spesso battuto strade sbagliate. Per esempio, non ha mai voluto accettare che quella superficie mutilava il mio tennis di una parte fondamentale: la palla corta, che usavo per manovrare, attaccare, variare, chiudere. Quei prati non erano quelli di oggi (superfici dove l’obiettivo è uniformare tutto, velocizzando la terra e rallentando l’erba Ndr). Vedo vincere Wimbledon dalla riga di fondo, mentre allora i rimbalzi erano difficili da gestire e solo Borg aveva la rapidità per dominarli, nessun altro. Si cercava di colpire sempre al volo. Io non avevo il tempo per preparare la palla corta, però quella volta giocavo nei quarti contro Pat DuPré. Stavo vincendo e giocando bene. 6-3, 4-0. Cominciai a pensare alla finale con Borg: volevo arrivare lì, ero l’unico ad averlo sconfitto a Parigi, volevo essere quello che lo fermava anche a Londra. Ci pensavo davvero, anche troppo e mi s’impicciò il match: lui vinse sei giochi di fila. La partita si allungò ma ne avevo smarrito il filo, per distrazione, per mancanza di rispetto dell’avversario, calcolandone un altro lontano, mentre ne avevo uno ancora in corsa dall’altra parte della rete. È l’unico rimpianto che ho: siamo qui a parlarne, anche quarant’anni dopo. In semifinale ci sarebbe stato Roscoe Tanner, l’avrei battuto, credimi. Quella finale con Borg volevo giocarla, potevo farlo».
Nemica era invece la stagione americana: «Per giocare lo US Open con qualche possibilità, bisognava partire dopo Wimbledon e stare due mesi negli Stati Uniti. Quel periodo lo soffrivo, è stato un mio limite, forse di mentalità: là vinse Manuel Orantes, potevo farlo anch’io. Il tennis per giocare bene sul cemento l’avevo ma fuori dall’Europa pativo la mancanza di globalizzazione del nostro tennis e delle nostre abitudini. Tutte: pratiche, alimentari, culturali. Poi cambiavano le temperature, gli odori, i sapori, spesso era caldissimo, come quella volta che a Forest Hills (ancora c’erano i campi in erba allo US Open, Ndr) si giocava con 45 gradi. Aspettavo la mia partita e decisi di andare a vedere cosa faceva Bertolucci. Con Paolo siamo cresciuti insieme, giocando contro: nella prima partita da avversari avevamo nove anni. Nei match di doppio non ci davamo il cinque a ogni scambio: non serviva, ci sapevamo uniti e non dovevamo rivedere o ritoccare le tattiche a ogni punto.
Insomma, mi avvicino su un campo laterale e lo vedo seduto al cambio campo, il volto paonazzo, tendente al viola. Boccheggiava. Gli chiedo: che succede? Lui mi indica il sole cocente e poi l’avversario, un neozelandese, che lo sbatteva da una parte all’altra del campo. Gli dico, quasi scherzando: e allora vieni via, che vuoi cuocere in campo? Mi allontano per prepararmi al match, faccio trenta metri e mi sento chiamare: Adriano aspettami!». Era Paolo, come fece poi quella volta a Santiago del Cile, quando trovò le forze per sfidare il carcere, assecondando le richieste dell’amico. «Era venuto via, ritirato per sfinimento. Succedeva anche a me, in America finivo per mancare di forza e per giocare il mio tennis – come ho detto - dovevo stare bene fisicamente».
Zeljko Franulovic è stato un tennista forte, completo, tenace, ottimo palleggiatore: avversario perfetto per Panatta, che anche a Parigi (come in tutte le altre occasioni, a parte una sconfitta in gioventù) ne ha disposto con agio, con variazioni tali da impoverire gli schemi dell’altro, costretto a soluzioni troppo difficili per contenere gli attacchi di Adriano, attratto come il destino da quella partita con Borg.
«Il trofeo di Roland Garros l’ho perso. Ero sicuro fosse in soffitta, finché non l’ho più trovato. Chiesi a mia madre se ne avesse avuto traccia e mi rispose semplicemente: boh... Ma credetemi, era una coppetta, il valore sentimentale ce l’ho dentro» Adriano Panatta
Quarti di finale: Adriano Panatta b. Bjorn Borg 6-3 6-3 2-6 7-6
Un giorno Jimmy Connors si arrese: «Ho dovuto allenarmi tanto, e correre tantissimo, e colpire tutto, provare a far giocare sempre un colpo in più. Io mica sono nato con il talento di Panatta». Questo pensavano di Adriano.
«I campioni della mia epoca mi hanno sempre rispettato e io andavo d’accordo con tutti, a parte Lendl: dopo il doppio 6-0 in Davis (vittoria in quattro set, con gli ultimi due finiti con l’allora cecoslovacco incapace di vincere un game Ndr) se la prese e non mi salutò per un pezzo. Però ci siamo rivisti a Parigi e mi ha abbracciato. Il tempo passa anche per lui, adesso perfino ride, ogni tanto». Se capita ogni tanto di sentire Panatta brontolare con il presente, c’è quasi sempre di mezzo un angolo troppo numeroso, il nutrizionista personale, il fisioterapista, lo psicologo, troppa gente: «Erano altri tempi ma non eravamo meno professionisti: certamente non così assorbiti, fanatici. Ci allenavamo insieme, nei campi liberi durante i tornei. A cena capitava di incontrarsi. Se perdeva, veniva anche Borg, finalmente rilassato, anche se con lui c’era sempre Lennart Bergelin che lo teneva silenziosamente sotto chiave. Bjorn era il matto calmo: sul campo, isolava tutte le insicurezze, le pulsioni: ti logorava la sua resistenza, la distanza dalle emozioni, la forza geometrica degli schemi, la capacità di alzare il livello quando serviva.
A lui piaceva frequentare noi italiani, ci vedeva allegri, liberi. A noi imbarazzava il suo modo di proporsi, di aggregarsi: era vestito male, impresentabile, direi perfino uno straccione. Una volta Bertolucci si fece dare la carta di credito e lo portò a fare shopping, così l’abbiamo vestito in maniera presentabile per il ristorante. Nello stile eravamo noi i campioni». Panatta fu l’unico tennista a sconfiggere Borg a Parigi. Lo svedese, tolto Adriano, non perse mai. Mai. Nel 1977 non ci andò, per una protesta sul prize money, reputato scarso: con lui marcarono visita anche Connors, Gerulaitis e Orantes, fra i più forti. Borg rimpiazzò quella data giocando un’esibizione per il circuito del Word Team Tennis che lo riempì di soldi. Per il resto, otto partecipazioni, sei titoli, due eliminazioni contro Panatta che sapeva togliere qualcosa al fenomeno.
Il tempo, anzitutto. E la serenità, inceppando quella danza fra un angolo e l’altro, costringendolo a una metrica stramba. Il senso del campo, che rendeva il palleggio di Borg quasi un’esercitazione più che una tattica. La presa della rete, con una sensibilità tattica e non solo tecnica, che narcotizzava il passante d’approccio di Borg: «Se stavo bene, sapevo di avere le armi per metterlo in crisi, per metterlo fuori quadro. E se contro questi campioni sai di poterlo fare, hai già fatto qualcosa. Lui era incredibile e un episodio a Marbella restituisce la sua eccezionalità. Eravamo là per un’esibizione, io contro lui, il vincitore intascava trentamila dollari in più. La sera prima andiamo a cena insieme e lui beve di tutto. Lo porto a casa sorreggendolo, era ubriaco fradicio. Lo metto a letto e vado a dormire contando già i soldi della vittoria: la mattina dopo finì 6-2 6-1 per lui».
Forse bere era come imbrogliare i complessi d’inferiorità (sissignori) dello svedese verso Panatta. Chissà. Forse il tennis di Panatta (come poi in modo dirompente e definitivo quello di McEnroe) ricordava a Borg quale fosse il difetto nella sua stoffa. In quel contrasto, c’era qualcosa che testimoniava il passato, la storia di sempre e di tutti, come una specie di architettura originaria che prevede le due cose insieme e può esaltarle solo nel duello. Anche impari. «Mi colpì molto in quegli anni un film di Spielberg, credo il suo primo lavoro, Duel. Una macchina e un camion che si sorpassano, si sfiorano, si provocano. Due aspetti così diversi della modernità, leggerezza e pesantezza, umanità e disumanità (del camionista non si vede mai il volto, come fosse la robotica che avanzava minacciosa in quegli anni Settanta) che si scontrano: per sopravvivere o sopraffare. Un duello insensato, eppure inevitabile. Forse con Borg – che ha cambiato il tennis, lo ha muscolarizzato e brutalizzato – io lottavo per far sopravvivere qualcosa di questo sport, dei suoi gesti».
«Avessi un diciottenne pieno di talento gli consiglierei di mettersi intorno le persone giuste, che sanno cos’è il tennis, per migliorare le debolezze e crescere le qualità. Gli suggerirei di curare il servizio, di andare avanti, per quanto oggi possibile contro questi atleti che sanno ributtare tutto. Di lasciar perdere motivatori, psicologi, guru: l’obiettivo di un tennista è migliorare il suo gioco, di questo si nutre e questo lo rasserena» Adriano Panatta
Semifinale: Adriano Panatta b. Eddie Dibbs 6-3 6-2 6-4
«Non ho mai giocato così bene. Ero già arrivato due volte in semifinale a Parigi: l’anno prima persi con Borg, con pochi rimpianti, tre anni prima con Pilic, con molti rimpianti. Forse per troppa sicurezza, chissà. Potevo vincere, dovevo vincere, persi netto. Credo che già allora avessi il livello per vincere Roland Garros; su quei campi avevo già sconfitto Ilie Nastase quand’era numero uno del mondo e Borg. Ma non avevo ancora la testa per gestire quelle due settimane fatte di tante partite, spesso lunghe, tanti giorni vuoti e pieni, tante attese che bruciano energie. Vincere al Foro Italico fu come assimilare l’obiettivo di Parigi. Ero pronto. E contro Dibbs giocai la partita perfetta: ogni colpo, un punto. Ero sciolto, sicuro, forte sulle gambe e nella testa, è un ricordo di naturalezza che ancora mi pervade. Sapevo casa fare e riuscivo a farlo».
La visione, o più pedagogicamente, la visualizzazione del suo sport è sempre stata netta in Panatta. Anche i ragazzi che poi ha guidato da capitano di Coppa Davis lo ricordano per l’intuizione giusta, al momento opportuno: «A fare il coach che sta tutte le ore sul campo e tutti i giorni addosso al giocatore non ho mai pensato, non sarei portato. Ma un difetto posso correggerlo, un consiglio posso darlo». Forse il Ct era davvero il suo ruolo, e fu lui, nemesi, a dover gestire il riflusso del dopo-Panatta (e dopo Barazzutti, e dopo Bertolucci). «Fra i ragazzi della Davis, Canè e Camporese erano i più forti: Paolo mancava di potenza e struttura fisica, Omar di mobilità. Avevano il talento per essere nei Primi Dieci del mondo». Ripensa ai ragazzi e affiorano gli aneddoti. Accanto a noi c’è Stefano Pescosolido, che una volta portò via in braccio per i crampi (a Maceio, in Brasile) e al quale chiedeva una sola conferma prima del match: «È carico il fucile? Sì? Ecco, scaricalo in campo». Bruguera fu crivellato, un’ora di tennis mai visto, mai giocato, 6-0 6-1 al numero uno del mondo sulla terra battuta, a casa sua, in Spagna. Peccato che intorno lo spagnolo vinse i restanti tre set, ma quell’ora di Pescosolido resta.
«A Maceio fu decisivo il doppio. Al quinto set Camporese e Nargiso erano avanti di un break, 1-0 subito dopo aver ripreso i due set di svantaggio. Sembrava fatta. Batte Diego, gli sussurrò un consiglio: sono spaesati, tieni in campo la prima, andiamo sul sicuro. E Nargiso fa quattro doppi falli». Il napoletano dev’essere stato un esame di pazienza, non sempre vinto. «Quella volta che non feci giocare Canè e Nargiso in Svezia? Si allenavano, tre scambi, due bestemmie, una racchetta tirata sui teloni, un’altra spaccata. Uno spettacolo indegno. Li osservavo dalla tribuna. Scesi in campo: ragazzi, piantatela. Se continuate così, non vi faccio giocare. Torno in tribuna: stesso spettacolo. Mi limitai a comunicarlo: domani non giocate. Canè – che alla Davis teneva tantissimo – mi supplicò di farlo giocare. Io mai mi sarei privato di lui. Gli volevo bene. Ma dovevo rivendicare il ruolo».
Si accorge della mia passione per gli aneddoti, sa – l’ho avvertito – del mio amore per Canè. Mi accontenta. La trasferta più strana è stata quella in Corea, per non retrocedere. Paolo perde il venerdì, Claudio Panatta (il fratello di Adriano) sistema le cose, il doppio (Canè-Colombo) ci porta in vantaggio, poi piove e tutto si dilata. Claudio perde il lunedì. Poi piove ancora e il quinto match si gioca il martedì. Adriano ai giornalisti dice di essere stufo di cucinare pasta a un gruppo ormai nevrotico, accarezza perfino l’idea del rimpatrio, in caso di nuovo rinvio. «Eravamo sfiniti, doveva essere una passeggiata e invece stavamo in Corea da dieci giorni, con l’incubo di una figuraccia infinita, retrocessione inclusa. Ma Canè è avanti 5-2 nel terzo set e serve per il match. Al cambio campo ascolta parlottare nel nostro box frasi del tipo: finalmente, prendiamo tutto e prepariamo i bagagli. E non dimentichiamoci dei visti! Paolo s’incazza: cosa fate? Io sono qui che lotto e voi preparate i visti? Ora ve lo faccio vedere io. Vado in campo e perdo. Torna in campo: tre colpi fuori di cinque metri e un doppio fallo. Ci guarda sfidandoci: vi tengo qui altri due giorni. Mi alzo, vado verso di lui, in campo, irritualmente, cerco di stare calmo, lo fisso e gli dico, piano piano: Paolo, se non chiudi la partita ti ammazzo. Te lo ripeto: se non vinci subito ti ammazzo qui, in campo, davanti a tutti».
Si salvò l’Italia e si salvò Canè. «Avessi un diciottenne pieno di talento gli consiglierei di mettersi intorno le persone giuste, che sanno cos’è il tennis, per migliorare le debolezze e crescere le qualità. Gli suggerirei di curare il servizio, di andare avanti, per quanto oggi possibile con queste racchette, questi atleti che sanno ributtare tutto. Di lasciar perdere motivatori, psicologi, guru: l’obiettivo di un tennista è migliorare il suo gioco, di questo si nutre e questo lo rasserena».
In quindici giorni Adriano divenne un nome comune, un inquilino di casa. Il tennis entrò nelle possibilità e nelle abitudini di molti. «Ho portato questo sport nelle case degli italiani»
Finale: Adriano Panatta b. Harold Solomon 6-1 6-4 4-6 7-6
Un tempo lo spogliatoio era un posto intimo e quel giorno c’erano solo loro due, i finalisti. Oggi nel tunnel arrivano anche le telecamere e sbirciano staff sempre più numerosi: chi si occupa di muscoli, chi di tattiche, chi di cervelli resi fragili forse proprio da questa promiscuità. «Il giorno della finale è ancora più sacro. Si comincia in 128, si resta in due. Lo spogliatoio è silenzioso, irreale. Eravamo io e Solomon. Lo chiamavo il sorcio tanto era brutto. Non gli faceva particolarmente piacere, non aveva quel senso dell’umorismo. Eravamo pronti, erano arrivate anche le scarpe da Roma (le mie se l’era prese per sbaglio Bertolucci) e aspettavamo solo la chiamata per entrare in campo. C’era un grande specchio e lo convocai: «Harold, vieni qua – e lui si avvicinò a me, riflessi nella parete –. Guarda un po’, gli dissi, secondo te chi deve vincere Roland Garros?». Non era superbia, né arroganza o forse entrambe le cose comunicate con la solita pura leggerezza da Panatta, che poté poi rivendersi la cinica battuta come un guadagno psicologico contro un avversario tenace, spesso battuto, come quella domenica nella quale gli idranti annaffiavano spesso il campo e talvolta anche le tribune: «C’erano quaranta gradi, dovevo gestire il sorcio e il caldo, ma ero sicuro di vincere, anche quando persi il terzo set, per rifiatare».
Parigi fu vinta, dopo Roma. Era successo qualcosa nella storia e nel costume del Paese, in quindici giorni Adriano divenne un nome comune, un inquilino di casa. Il tennis entrò nelle possibilità e poi nelle abitudini di molti. «Ho portato questo sport nelle case, l’ho capito dopo, smettendo, incontrando la gente, viaggiando l’Italia con i tempi per capirla». Nei piccoli paesi si costruirono campi, arrivarono maestri con gesti eleganti e racchette di legno. Quattro o cinque generazioni di connazionali indossarono pantaloni assai corti e polo. Qualcuno si pettinava come lui, il ciuffo era una moda, i capelli lunghi un segno di personalità e – dopo quei quindici giorni – di imitazione. Solo una Federazione piccola e vendicativa poteva escluderlo dalla storia degli Internazionali, con argomentazioni spacciate per logiche, invero puerili. Ma figuriamoci se questo lungo ricordo può esserne inquinato: Panatta è tenacemente presente nella memoria di un popolo, in quel valore inestimabile che è l’immaginario collettivo.
«Il trofeo l’ho perso, si sa. In un trasloco, ma ero sicuro fosse in soffitta, finché l’ho cercato e non l’ho più trovato. Chiesi a mia madre se ne avesse avuto traccia e mi rispose semplicemente: boh... Ma credetemi, era una coppetta, il valore sentimentale ce l’ho dentro, quello conta. Se qualcuno non mi costringe a farlo, non rivedo mai le immagini di nessuno dei miei incontri. Non ho nostalgie. Nemmeno smettere per me fu difficile. Era il momento e non avevo paura. Mai stato maniacale, mai riuscito a spersonalizzarmi in campo: forse mi è costato qualcosa, ma ci ho guadagnato serenità e quando incontro i tennisti della mia epoca mi sembrano tutti invecchiati peggio di me». Lui è stato l’ultimo – ruolo un po’ esiziale – eppure ebbe l’impatto del pioniere, del primo. Essere l’ultimo (a vincere lì, a vincere là) assicura una presenza nei discorsi pubblici, finché qualcuno non sostituisce quel nome. Ma, per quanto detto, Panatta resterà. Ha la biografia e lo sguardo di chi ha saputo vivere: «Sono stato curioso, delle persone e dei luoghi, delle possibilità della vita e del pensiero, mi piaceva sentirmi nel traffico delle cose, circondato da amici, dalla famiglia. Mi manca Paolo Villaggio, la sua intelligenza che manifestava nella sua forma più sublime: l’ironia. Chi non ha senso dell’umorismo mi ha sempre fatto un po’ paura».
Parliamo ancora un po’ di musica, di cinema, di calcio, di quel libro e di quel politico che sembra l’imitazione di quell’altro, ugualmente efficace nel distruggere per egocentrismo il senso condiviso delle cose. In tv, trasmettono tennis e Adriano si accende una sigaretta.