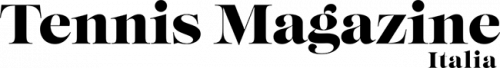Qual è il tuo Personal Best?
La nuova campagna Asics suggerisce una riflessione su come interpretare l’attività sportiva, affermando che le sensazioni che si provano sono più importanti del risultato. Un concetto che permette di vivere lo sport in maniera sana, a patto di... imparare a perdere. E il tennis è un buon insegnante
di Lorenzo Cazzaniga | 16 ottobre 2023 |
La nuova campagna di Asics che invita a condividere il proprio personal best nello sport è di quelle che fanno bene perché non ha (solo) l’obiettivo di promuovere un brand o un prodotto, ma suggerisce una pratica sempre meno diffusa: la riflessione. Senza essere divisiva come la storiella della bambina e la pesca, ci pone di fronte a un dilemma per nulla banale e che può raccogliere opinioni opposte. Il claim è piuttosto chiaro: a personal best is not a number. It’s a feeling, e ridefinisce un concetto tipico dello sport dove tutto è misurabile con un cronometro, un punteggio, una statistica. Billy Beanie non è solo il protagonista di un bel film interpretato da Brad Pitt (Moneyball, tratto dal libro Moneyball: The Art of Winning an Unfair Game di Michael Lewis, pubblicato nel 2003) ma l’artefice di una rivoluzione sportiva dove i Big Data sono diventati lo strumento imprescindibile per giudicare un atleta. Ogni movimento di un giocatore di tennis, calcio, basket, baseball, golf, eccetera, viene vivisezionato per verificarne le caratteristiche e giudicarne l’efficacia.
Negli Stati Uniti, la statistica applicata allo sport è una religione che impiega diversi data analyst, occupati nottetempo a scovare indici di valutazione certi che l’occhio umano potrebbe, al più, ritenere probabili. Se torturi i numeri abbastanza a lungo, confesseranno qualsiasi cosa, sostengono gli esperti di analisi che affiancano i coach nel lavoro quotidiano con gli atleti, fornendo alcuni strumenti determinanti per migliorare la performance e arrivare all’obiettivo finale che il mito (per gli americani) Vince Lombardi ha riassunto così: «Vincere non è la cosa più importante, è la sola cosa importante».
Un’opinione ovvia quando sei considerato il miglior coach di sempre negli sport americani, al punto che il trofeo del Superbowl porta il tuo nome. Tuttavia, quando lo sport si sposta dal professionismo all’amateurismo, il concetto rischia di diventare fuorviante, perfino pericoloso, soprattutto se applicato a giovani atleti che, nella stragrande maggioranza dei casi, non hanno lecite speranze di ambire allo sport di vertice. Secondo una ricerca condotta tra gli sportivi italiani, il 46% ha dichiarato di sentire un forte imbarazzo nel frequentare una palestra perché ritiene di non corrispondere al tipico soggetto che le frequenta, il 75% vorrebbe avere più fiducia in se stesso per affrontare una pratica sportiva e il 38% di avvertire una sensazione di fallimento quando vedono contenuti che esaltano l’attività fisica sui social media. Numeri un filo inquietanti considerando che l’87% è comunque consapevole dei benefici psico-fisici dello sport. Per questo motivo, Asics ha scelto come testimonial persone comuni che possano rappresentare un benchmark più ragionevole, dove l’obiettivo diventa il benessere e non il risultato.

Stefano Baldini, oro olimpico ad Atene 2004 nella maratona
Però, al contempo, riaccende il duello che fa scomodare Lombardi: lo sport va vissuto come eterna rincorsa della vittoria o alla ricerca di una sensazione di benessere? Vincere o perdere è comprensibilmente determinante quando ci si gioca il trofeo di Wimbledon e un prize money milionario, ma può esserlo anche quando si tratta di un innocente match del torneo sociale? Non esiste una risposta che soddisfi tutti. I casi come quello di Dalila Setti, storica giornalista di Sky Sport e testimonial della campagna Asics, che considera il tennis una presenza essenziale nella sua vita ma che riesce a viverlo con estrema naturalezza, non è necessariamente la norma: «Se mi guardi a fine match, difficilmente capirai se ho vinto o perso» dice. Personalmente invece, in quarant’anni passati sui campi da tennis, ho visto stimati avvocati, commercialisti e businessman abituati a gestire forti tensioni, spaccare un paio di racchette dopo un dritto finito lungo o rubacchiare un punto quando il rimbalzo è dubbio e lo scambio decisivo, financo a rischiare la rissa con l’avversario.

Serve equilibrio, suggeriscono i saggi. Un primo step sarebbe passare dalla categoria dei risultatisti a quello dei giochisti, per soffiare due termini orribili al calcio. I primi sono dipendenti dal risultato, un concetto accettabile solo a livello pro. Tra i ragazzi, il rischio è quello di inseguire un traguardo immediato (leggi gli effimeri successi junior) e dimenticare la meta finale. Gianluigi Quinzi è un buon esempio: doveva essere il nuovo Messia del tennis azzurro, ancor prima di Jannik Sinner. Tra gli junior ha vinto Wimbledon (2013), tra i pro un solo match del circuito maggiore nel quale ha raggiunto un best ranking da numero 142 ATP; e qual è stato l’inciampo maggiore? Assecondare il desiderio (non solo suo) di vittoria istantanea a qualsiasi costo, senza accorgersi che serviva un percorso di crescita diverso. Quasi fosse inammissibile che, per raggiungere la lode all’università, dovesse prendere qualche brutto voto al liceo. Ecco, quando l’obiettivo diventa vincere a ogni costo, è questo ogni costo a diventare un pericolo. Vale, ça va sans dire, anche a livello amateur. Invece, è più comprensibile la delusione per una cattiva prestazione perché i giochisti non si legano al risultato ma alla capacità di far bene quanto si è capaci di fare. E giocare bene è un obiettivo più sano che vincere a ogni costo.
Vincere o perdere è comprensibilmente determinante quando ci si gioca il trofeo di Wimbledon e un prize money milionario, ma può esserlo anche quando si tratta di un innocente match del torneo sociale?
Quando però si tratta di teen-agers, c’è anche chi sostiene che lo sport possa aiutare a forgiare un carattere resiliente e una mentalità vincente. Ci sono validi esempi a supporto. Tuttavia, bisogna essere coscienti che c’è anche il rischio contrario, un burn out che ha generato reazioni drammatiche anche ad altissimo livello: vale dunque la pena rischiare, soprattutto quando è evidente l’idiosincrasia con la competizione? E non avere un acceso spirito competitivo nello sport, ha davvero come naturale conseguenza quella di formare una personalità poco spiccata? Assolutamente no. Lo sport non è sempre lo specchio della vita. Anzi, talvolta riflette una personalità opposta. Invece, soprattutto tra i giovani, può essere motivo di ansia e depressione, patologie molto più frequenti di quanto si possa pensare, come testimoniato da quel 41% di intervistati che ha dichiarato di aver conosciuto personalmente, o attraverso una persona vicina, un problema di salute mentale. Il 41%.
Quando l’obiettivo diventa vincere a ogni costo, è questo ogni costo a diventare un pericolo
Tuttavia, l’inseguimento di un obiettivo, anche statistico, non è il male assoluto, se non si trasforma nell’unico motivo che spinge allo sforzo. In definitiva, per vivere lo sport in maniera sana, fisicamente e mentalmente, come insegna la campagna Asics (non a caso l’acronimo di Anima Sana In Corpore Sano) bisogna semplicemente... imparare a perdere. Prendiamo l’attività fisica più comune, la corsa: anche il runner da cinque chilometri in trenta minuti (il sottoscritto, con due energy drink in corpo) non si smuove senza essere assistito da una app di stalkeraggio che ti indica i chilometri percorsi, la velocità media, la lunghezza del passo, il dislivello raggiunto, le calorie consumate. E che appena schiacci start, ti domanda se vuoi sfidare la sessione precedente, e tu scatti come se stessero provando a scipparti la borsa pur di metterci un secondo meno della volta prima. Questo stimolo non è necessariamente malvagio perché ti stacca da Netflix & Co., a patto che non si trasformi in ossessione, perché il benessere di quella sgambata non deve dipendere da quel secondo in meno. Accettare la sconfitta è invece il processo che ci consente di vivere lo sport come inesauribile fonte di piacere. Andre Agassi, nel suo splendido Open, dice che saper perdere è molto più difficile che saper vincere. Anche nel tennis, dove la sconfitta è un’eventualità piuttosto frequente: «Sapete perché il tennis è così odiato negli Stati Uniti? Perché ogni giorno due milioni di americani giocano una partita e un milione di loro perde».

Però accettare un fallimento richiede uno sforzo psicologico non banale. Qualsiasi tennista di vertice a cui ho avuto modo di porre la domanda, mi ha confermato la stessa cosa: la delusione per una sconfitta è un sentimento più forte e duraturo della gioia che provoca qualsiasi successo. A quasi quarant’anni di distanza, John McEnroe fatica ancora a entrare sul campo centrale di Roland-Garros perché il ricordo di quella volée comoda finita larga che gli ha impedito di vincere il French Open e, probabilmente, di conquistare il Grand Slam, è ancora troppo vivo. Così come la finale di Wimbledon 2019 persa dopo aver mancato due match point consecutivi, è argomento tabù in casa Federer. E questo nonostante il fuoriclasse svizzero abbia perso altre 274 partite da professionista, una ogni cinque che ha disputato. A quei livelli, non è raro che certe situazioni diventino drammatiche, al punto che campioni come Mardy Fish o Naomi Osaka hanno scelto di allontanarsi dal tour per questioni di salute mentale.
In ogni caso, il tennis rimane uno sport affascinante quanto educativo proprio perché insegna a perdere. Costantemente, settimana dopo settimana. E, piano piano, impari a farlo come insegna Amy Gardner in West Wing: «Ho combattuto, ho perso, ho bevuto un drink, ho fatto una doccia. È così che funziona tra professionisti. E sai cosa faccio quando vinco? Due drink».
Lo sport, comunque lo si interpreti, ha una qualità fondamentale: fa riflettere. In un mondo che va di fretta, è già un personal best.